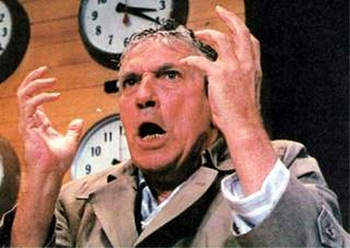
Chi legge queste pagine e in particolare segue la rubrica semisegreta intitolata al tarlo, conosce l’attenzione che dedichiamo al tema dell’attendibilità dell’informazione ai tempi del web.
Come abbiamo ripetuto fino alla noia, mentre il web ingloba e sostituisce il quadro mediatico tradizionale, i paradigmi fondamentali che hanno retto il giornalismo professionale per qualche secolo stanno crollando, sostituiti da modelli molto meno tracciabili, il cui fondamento filosofico è interamente poggiato sulla supposta capacità dell’utente finale di riassumere le funzioni di selezione e comprensione dei fatti tipiche della nozione classica del giornalismo.
Risultato di aver eletto a pilastro della transizione una teoria non preventivamente verificata, è che dopo più di tre lustri di Web e una decina d’anni di “Web 2.0”, il problema della tracciabilità delle informazioni è quantomai concreto. Dalla pura e semplice disinformazione, fondata su una conoscenza parziale e orientata ideologicamente dei problemi affrontati, all’interesse economico del blogger che scioglie ditirambi sul gadget che gli è stato dato in omaggio, al lettore tocca ogni giorno navigare fra montagne di informazione-spazzatura, o piuttosto arrendersi all’imperscrutabile logica di un motore di ricerca.
Timu – è questo il nome dell’iniziativa di cui parliamo – tenta di tamponare il problema della credibilità dell’informazione sul Web, proponendo una metodologia basata su quattro criteri: accuratezza, imparzialità, indipendenza e legalità.
L’adesione è ovviamente volontaria e il progetto propone una serie di incentivi alla partecipazione tra cui, ovviamente, la visibilità, anche presso i media tradizionali.
Alle molte buone intenzioni propugnate dal progetto e dalla fondazione che gli sta alle spalle, corrisponde una apparente congenita mancanza di efficacia nell’esecuzione dei principi dichiarati: non esistono organismi preposti al filtraggio e controllo qualitativo dei contenuti.
In altre parole non c’è un direttore responsabile, ossia qualcuno – oltre all’autore – che si assuma la responsabilità, davanti al lettore e alla legge, di sottoscrivere l’aderenza del pezzo ai quattro principi enunciati. Il punto della FAQ intitolato “qualcuno controlla i miei contenuti” recita infatti:
No. Non c’è nessuna attività di filtro o controllo da parte di <ahref. Se hai scelto di condividere il metodo che ti proponiamo non ce n’è la necessità. <ahref interviene solo nel caso in cui siano segnalate da terzi sui tuoi contenuti violazioni di legge e lo principalmente a tua tutela. Ma anche in questo caso la prima valutazione che verrà fatta da parte nostra per decidere come agire sarà quella di verificare se hai applicato correttamente i termini del patto per la informazione di qualità che ti sei impegnato a condividere e a migliorare insieme a noi.
Al di fuori delle generiche rassicurazioni previste nel paragrafo menzionato, non esistono fra i principi fondamentali dello statuto, menzioni esplicite circa forme di copertura legale per gli autori dei contenuti ospitati.
Concludendo, mi pare che l’iniziativa vada nella direzione giusta quando promuove un miglioramento dei processi alla base del giornalismo partecipativo, ma inevitabilmente erediti i limiti strutturali di questo modello.
L’idea di fungere da ponte fra il citizen journalism e i mass media è poi interessante, ma meriterebbero un chiarimento le modalità, con particolare riferimento alla tutela legale: in un’economia dominata da lobbies con schiere di avvocati a libro paga, l’informazione per rimanere libera ha bisogno di soldi più che di buone intenzioni.









