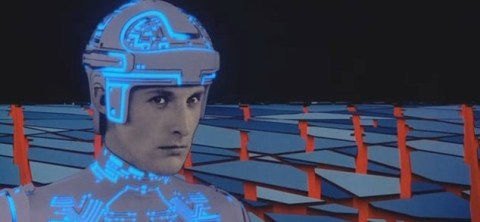
Tranquilli: non ho ancora perso la ragione (almeno per ora). La domanda prende spunto da una vecchia discussione nel forum di hardware upgrade dove, parlando della situazione lavorativa dei programmatori, un utente fece una battuta sull’argomento che suonava più o meno così:
I programmatori, come le donne di facili costumi, traggono godimento dall’esercizio della loro attività. Quindi perché dovrebbero essere pagati?
Ci divertiamo, insomma, per cui la retribuzione sarebbe superflua. A parte l’insignificante dettaglio che anche i programmatori dovrebbero mangiare (lo fanno persino i filosofi, che all’attività del pensare alternano i pasti), siamo sicuri che la situazione sia così rosea come la si dipinge?
L’idea del programmatore appagato dal proprio lavoro è alquanto idealizzata o, meglio ancora, romanzata, nonché spesso circondata da quell’aurea di nerdaggine che tende a relegare quest’attività a gente grassa e brufolosa, dotata di fondi di bottiglia, e perennemente tappata in casa a vegetare davanti alla tastiera.
Non proprio il massimo della vita, insomma, ma… si è felici! Perché programmare è bello! E’ pura goduria! Essendo un’attività particolarmente creativa, può risultare anche divertente e portare gratificazione (spesso autogratificazione e autoesaltazione).
Ricordiamo quando, alle prime armi, impugnavamo la tastiera e smanettavamo cercando di piegare il metallo al nostro volere, con la spensieratezza di chi poteva permettersi anche 13 ore filate a esercitare i polpastrelli con gli occhi incollati alla TV (quando i monitor erano merce rara e molto costosa), con la mamma a gridare in continuazione “è pronto!” e noi a rispondere sempre “un secondo, finisco una cosa, e arrivo!”
Ma nella naturale evoluzione e crescita di un essere umano prima o poi tocca rompere il cordone ombelicale (virtuale) e cercare o inventarci un’attività che ci possa rendere economicamente autosufficienti. Si smette di programmare per pura passione, per il piacere di farlo, e si passa a farlo per necessità.
Capita, quindi, di avere a che fare con lo sviluppo di software che proprio non ci piace, ma lo si comincia a capire già dalla scuola che non sempre possiamo fare tutto ciò che vorremmo. Costretti a seguire una pallosissima lezione sui segmenti dell’8086, quando con la testa vaneggiamo sui favolosi chip custom dell’Amiga.
Di peggio può capitare soltanto all’università, dove parlando con un professore che ha stima di noi confessiamo disinvoltamente di non voler mai avere a che fare coi database, perché li riteniamo roba assolutamente non interessante. Salvo scoprire che il suddetto presiede la cattedra di “Elaborazione dell’informazione non numerica”… materia obbligatoria del corso di laurea!
Ironia della sorte, da anni lavoro coi database, e la cosa non mi fa affatto schifo (a parte con MySQL, ma questa è un’altra storia). Idem per il web: “io sviluppare applicazioni web? Mai!” Ebbene, ne ho già realizzate, e in questi giorni sono alle prese con un nuovo progetto. E potrei continuare con altri esempi. Mai dire mai, insomma! Anche perché le opinioni su certi settori dell’informatica possono anche mutare, e ciò che prima disprezzavamo può addirittura rivelarsi piacevole…
Il programmatore, però, rimane pur sempre un lavoratore, uno che viene pagato per sviluppare codice che interessa all’azienda (e non a noi, che magari vorremo fare ben altro!) per la quale lavora, e a cui bisogna dar conto (mi sembra il minimo). Inoltre non passa il tempo da lupo solitario, ma spesso è richiesta interazione e collaborazione con altri colleghi.
Qui possono nascere altri problemi, per i più svariati motivi. Tanto per fare qualche esempio, può succedere di discutere in merito alle soluzioni da adottare per un particolare progetto, ma il nostro responsabile prenderà poi una strada diversa (sic!). Di avere accesi diverbi con altri colleghi che capiscono di astrazione e sviluppo del software quanto noi di bricolage, oppure coi sistemisti che vedono come fumo negli occhi le nostre analisi e soluzioni ai problemi che a volte saltano fuori. O, peggio ancora, veniamo accusati di ostruzionismo; come se ogni giorno ci svegliassimo e, soprattutto, venissimo pagati per mettere i bastoni fra le ruote agli altri. Ecc. ecc. ecc.
Magari non capitano tutte assieme (se si è particolarmente sfortunati, modello Fantozzi, sì), ma shit happens, come dicono gli inglesi. Perché ognuno è dotato di un background culturale, esperienze, capacità e approccio diversi alle varie situazioni con cui abbiamo a che fare.
Conciliare le idee di tutti non è affatto semplice, specialmente per chi ha l’ingrato compito di gestire l’insieme, ma è innegabile che la diversità crea attriti che possono provocare ricadute a livello personale sia nel lavoro che fuori (fino al punto di perdere serenità; e sonno, per chi è particolarmente sensibile).
Lavorare in certe condizioni può essere talmente frustrante da portare a scelte radicali o disperate. A volte veramente balzane. Ad esempio, in un periodo di crisi, un programmatore ha deciso di smettere di scrivere codice ed è andato a fare… il magazziniere!
Ciò detto, riusciamo almeno a portare il pane a casa. La situazione, in ogni caso, non è delle migliori nel nostro ambito lavorativo. Abbiamo speso anni per la nostra formazione, magari bivaccando un po’ troppo all’università, e una volta fuori e col pezzo di carta in mano (per quanto possa valere) ci sentiamo i padroni del mondo.
Ma il mondo la pensa diversamente, si passano mesi a spedire curriculum senza ricevere nessuna risposta, e quando arriva spesso si apre una porticina chiamata stage aziendale… tante volte non retribuito.
Pratica comune anche a settori diversi dall’informatica, per carità. Una sorta di schiavitù moderna, di cui i disperati nuovi servi della gleba devono far parte per aspirare al tanto agognato posto fisso (sempre che abbia senso con la mutevolezza del mercato).
Quando finalmente arriva, andando a leggere fra le righe della prima busta paga ci accorgiamo di essere… metalmeccanici. E neppure col miglior contratto (non c’è la quattordicesima, ad esempio). L’informatico è, in buona sostanza, diventato l’operaio sottopagato e sfruttato del nuovo millennio, causa eccessivo divario fra domanda e offerta.
Un quadro decisamente diverso e desolante rispetto al boom degli anni ’80, dove si favoleggiava di programmatori che andavano in giro con la Ferrari, realizzando videogiochi (chi non ha mai desiderato di crearne uno?).
Tornando al tema dell’articolo, direi quindi di sì: ce n’è abbastanza per potere affermare che lo stipendio che guadagniamo non è certo superfluo, visto che programmare di per sé non garantisce automaticamente soddisfazione, non sempre veniamo impiegati in quel che vorremmo, la retribuzione non è quella auspicata, possiamo avere problemi nell’ambiente di lavoro, o ancora non venire adeguatamente valorizzati.
Con ciò non voglio assolutamente generalizzare e affermare che la nostra attività ci porterà necessariamente a situazioni del genere, ma certamente è difficile che si riveli l’Eldorado sognato. Chi continua ad avere una visione romantica di questa professione è bene che torni coi piedi per terra e tenga presente che, per “bello” che possa essere, sviluppare codice è comunque un lavoro, da portare avanti con dignità e professionalità. Come per tutti.









