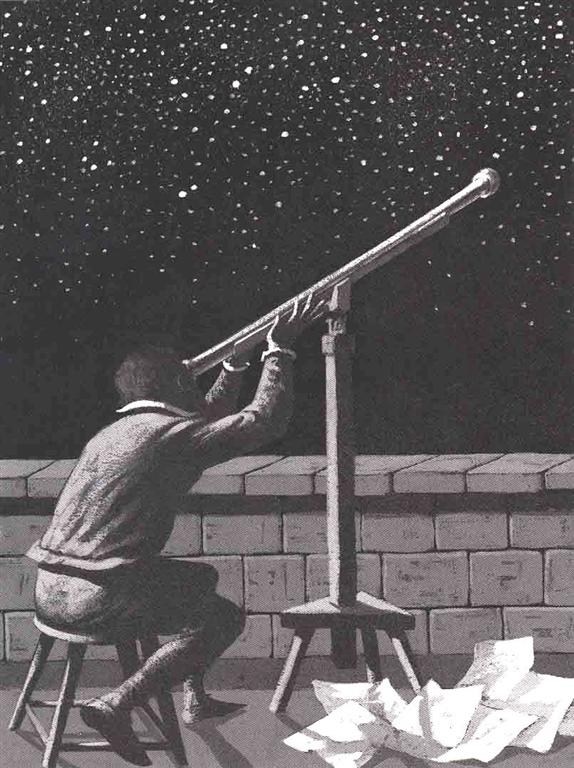
Nelle pagine di questo sito, così come in innumerevoli altre pagine di siti web, riviste, libri, trasmissioni radio televisive, e chi più ne ha più ne metta, sono stati trattati argomenti scientifici. Abbiamo qui commentato scoperte recenti, nuove e vecchie teorie e credenze comuni. Le informazioni che un individuo può riceve oggi sono praticamente infinite.
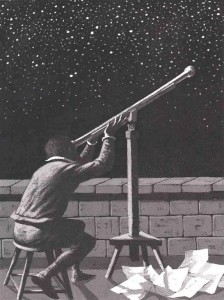
Spesso sento dire delle frasi del tipo: “la tua fede nella scienza è altrettanto cieca quanto la fede in qualsiasi altro fondamentalismo”. Questo discorso non farebbe una piega se non esistesse il metodo scientifico. Invece, la scienza non è una credenza, è semplicemente un metodo, un approccio per comprendere la natura.
Certamente non è il solo metodo, ma di sicuro è l’unico metodo affidabile. Questo perché si appoggia su una serie di passi successivi da seguire per arrivare ad una conclusione che ha un livello misurabile di verosimiglianza.
Notiamo come una teoria scientifica non propone mai una verità, ma esclusivamente una conclusione altamente corroborata e quindi probabile. Nella scienza più moderna, dove si assume un approccio statistico alla risoluzione di un problema, questa probabilità è misurata e viene presentata assieme alla conclusione stessa. Qualsiasi altro metodo di descrizione di un fenomeno naturale che non sia presentato secondo un ragionamento critico, non è affidabile.
Ogni scienziato deve imparare, nel corso della propria educazione, a seguire il metodo scientifico e, di conseguenza, ad avere un approccio critico a qualsiasi problema. Questo metodo di ragionamento non è facile e, di certo, non è naturale per l’uomo.
Spesso, si sarebbe più portati a seguire l’istinto, le proprie speranze e i propri sentimenti. Così facendo, però, non si raggiungerebbe una conclusione affidabile. Il ragionamento scientifico, o ragionamento critico, bisogna impararlo. Nonostante al giorno d’oggi la scienza sia diramata in numerosissime branche diverse, che utilizzano sistemi e strumentazioni molto diverse per trarre conclusioni, esse sono tutte accomunate dal metodo scientifico.
Se per chi sceglie di fare scienza è indispensabile imparare a pensare criticamente, è secondo me estremamente utile che chiunque sappia farlo. Se una persona è in grado di pensare criticamente e approcciare con metodo scientifico un problema, può applicare questa capacità a tutto: economia, politica, scienze sociali, vita di tutti i giorni. Molti problemi della nostra società verrebbero risolti immediatamente, se tutti applicassero il metodo scientifico alla propria vita.
Il metodo scientifico comincia con la formulazione di un problema o di una domanda. In questa fase è facile essere influenzati da fattori esterni non derivanti dalla logica scientifica. Per esempio spesso la scelta di quale argomenti sviluppare è guidata dalla politica o dalla società (come nell’ecologia o nella medicina) o in base alla disponibilità di mezzi e di fondi monetari.
È però importante notare come questo non influenzi il risultato, in quanto l’approccio critico è indipendente da queste scelte esterne. Una volta che si ha di fronte una domanda, si cerca di formulare una risposta. Questa risposta, nelle scienze, è detta ipotesi. Per formulare un’ipotesi non si segue l’istinto o la fede, ma si utilizza il metodo induttivo.
Secondo Aristotele, è possibile ottenere delle “verità” a partire dall’osservazione, tramite induzione. L’induzione, però, se è il primo passo nell’approccio scientifico, da sola non è sufficiente. L’ipotesi così formulata, infatti, non ha alcun valore scientifico, poiché necessita di essere validata. È importantissimo, nella scienza, sapere che non è possibile dimostrare la veridicità di un’ipotesi, ma solo falsificarla.
L’ipotesi, dunque, per seguire il metodo scientifico, deve essere falsificabile. Un’ipotesi è falsificabile quando è possibile sviluppare un esperimento o una teoria che dimostrano la falsità di questa ipotesi. Per esempio, l’ipotesi che il Bosone di Higgs esiste, non è un’ipotesi falsificabile. Infatti se un esperimento non lo trova, può solo dire che con il proprio metodo e la propria precisione non è stato possibile osservare il Bosone di Higgs, ma non può escluderne l’esistenza in generale.
Al contrario, l’ipotesi che il Bosone di Higgs NON esiste, è un’ipotesi falsificabile. Infatti, basta osservarlo per poteri dichiarare che l’ipotesi iniziale era falsa. Questa differenza è importantissima per avere un approccio scientifico ad un problema, perché una dichiarazione che non è falsificabile in nessun modo non può essere verificata, e quindi non è affidabile.
Il passo successivo è verificare quest’ipotesi. Classicamente si dice che per verificare un’ipotesi bisogna fare un esperimento. Questo è vero, ma al giorno d’oggi non è sempre possibile. Per verificare se la teoria cosmologica è vera, e l’Universo è in espansione, per esempio, non si può fare un esperimento, costruendo un piccolo Universo e riproducendo il fenomeno.
In casi del genere bisogna quindi raccogliere dati e fare una serie (lunghissima) di osservazioni. Una teoria scientifica, infatti, per essere tale deve descrivere tutti i fenomeni legati ad un certo problema.Nel caso dell’espansione dell’Universo, per esempio, si deve poter predire la velocità relativa delle galassie tra di loro, e questa quantità è misurabile tramite osservazioni.
Quando uno scienziato, o un gruppo di scienziati, hanno raccolto sufficienti dati per corroborare un’ipotesi, allora quest’ipotesi è pubblicabile e presentabile alla comunità scientifica. Il processo, però, non finisce qui. È infatti necessario che chiunque, munito dei mezzi e dell’educazione necessaria, sia in grado di riprodurre le medesime osservazioni e di corroborare a propria volta la teoria scientifica presentata.
Se questo passaggio fallisce, la teoria è smentita, e va eliminata o modificata. Nel momento in cui una teoria viene modificata o riformulata, è necessario ricominciare da capo nel processo di validazione. La riproducibilità di un esperimentoo di un’osservazione è fondamentale per il processo scientifico. Senza di essa la teoria non è valida e non è affidabile.
È secondo me importantissimo che qualsiasi essere umano cerchi, al massimo dei propri mezzi, di utilizzare un approccio critico per determinare se una teoria, un’informazione, o un metodo sia affidabile. Purtroppo questo approccio necessita impegno, fatica e volontà, e molti preferiscono evitarlo. Bisogna però sapere che non tutte le “verità” che ci vengono proposte sono sullo stesso piano.
Molte non sono verificabili, non sono riproducibili e non sono state formulate seguendo un approccio razionale. Queste “verità” non sono affidabili e pertando dovremmo evitare di prenderle in considerazione. Attenzione, non dico che siano false. Talvolta, magari, sono anche vere. Ma non sono verificabili e quindi non possiamo valutarne la veridicità o verosimiglianza. Per questo una persona di senno non dovrebbe prenderle in considerazione.
Il metodo scientifico non è certamente risolto in queste poche righe. L’induzione, la deduzione, l’empirismo, il razionalismo, la logica, sono concetti su cui trovate biblioteche intere. Spero di riuscire ad approfondire alcuni di questi concetti in queste pagine, ma come introduzione, spero di avervi convinto ad essere sempre “critici”!









